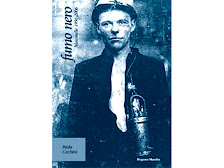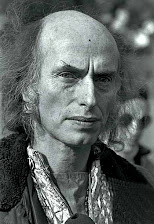di Roberto Torretta (sito web: Montessoro Web )immagine gentilmente fornita dal sito EllisIsland.com
Le storie d'immigrati che giornalmente ci appaiono in televisione e sulla stampa mi riportano ai racconti di mio nonno che era nato al Piazzo (Isola del Cantone) nel 1880 ed emigrò in California agli inizi del 1900.In cento anni, dal 1876 al 1976 circa, emigrarono 27 milioni di italiani; i nostri avi sono stati costretti ad emigrare verso i paesi più ricchi poichè da noi si moriva letteralmente di fame. Nel 1903 l'età media in Italia era di 25 anni. Tra il 1891 e il 1900 su 759.000 morti, 333.000 avevano meno di 5 anni.
Laceri, sporchi e analfabeti, erano imbarcati nelle stive stracolme di altri disperati provenienti dalle nazioni povere dell'Europa: Turchia, Grecia, Polonia ecc. Spesso non sapevano nemmeno dove la nave li avrebbe portati. Sbarcavano in paesi dove la gente non li aspettava di certo a braccia aperte. La maggior parte finiva per vagabondare e si dava all'accattonaggio, altri finivano nella malavita organizzata; i più furbi vivevano di espedienti, i più onesti venivano sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli.
Inizierò riportando alcune notizie riguardanti quegli emigranti che una volta giunti negli Stati Uniti volevano raggiungere la mitica California.
Pensando a questo lungo viaggio la prima cosa che ci viene in mente è quella delle lunghe carovane di pionieri che si spingevano sui pericolosi sentieri del Far West. Ciò non è però del tutto vero perché questa consueta immagine c'è stata inculcata dai mitici film western che abbiamo visto al cinema. Forse non tutti sanno che dal 1850 tanti emigranti per poter raggiungere la costa del Pacifico non viaggiavano via terra ma via mare.
Nel 1848, quando in California fu scoperto l'oro e vi fu la famosa corsa verso l'Ovest, per attraversare gli Stati Uniti l'unica via era la "California Trail", una pista lunga 3000 chilometri, e per arrivare a destinazione, se si arrivava, occorrevano anni. Una seconda alternativa, che molti sfruttavano, era quella di andare via mare passando per il Capo Horn ed impiegando 160 giorni; successivamente con i più veloci "cutter" ci volevano 60 giorni. A quell'epoca non c'erano altre scelte anche perché la costruzione della prima ferrovia New York - San Francisco iniziò soltanto nel 1862 ed i lavori furono ultimati nel 1869.
Una geniale idea venne allora al finanziere ed armatore americano Cornelius Vanderbilt il quale pensò di allestire una linea di traghetti da New York al Nicaragua e San Francisco.Bisogna sapere che in questo Stato del Centro America esiste un sistema naturale di vie navigabili che permette di passare dall'Oceano Atlantico al Pacifico senza la costruzione di canali artificiali; in questo modo i velieri di Vanderbilt partendo da New York attraversavano il Golfo del Messico e toccando la costa del Nicaragua a San Juan del Norte, risalivano il Rio San Juan che è navigabile e raggiungevano il Lago Nicaragua. Sulla costa occidentale di questo grande lago gli emigranti venivano fatti sbarcare e con vari mezzi attraversavano i 20 chilometri di giungla che separavano il lago dal porto di San Juan del Sur sul Pacifico. Da qui venivano imbarcati su un altro battello che li trasportava a San Francisco in California. Sembra addirittura che Mr. Vanderbilt, con l'appoggio degli Stati Uniti coltivasse un progetto per costruire nel tratto di terraferma un canale navigabile ma nel 1850 in base al trattato Clayton-Bulswer, l'Inghilterra non concesse l' esecuzione di tali lavori, un vero peccato se si pensa che il Canale di Panama venne aperto soltanto nel 1917.
In quegli anni il viaggio New York/San Juan del Norte durava 7 giorni mentre da San Juan del Sur a San Francisco ne occorrevano 17: in totale erano 24 giorni.
In quel periodo, comunque, oltre alla via del Nicaragua gli emigranti potevano raggiungere il Pacifico anche attraverso Panama (porto di Aspinwall), che come abbiamo visto non aveva ancora il canale, ma una ferrovia ultimata nel 1855, collegava le sponde dei due oceani. In questo caso però occorrevano 35 giorni.
L'armatore americano ebbe senz'altro una grande idea che gli fruttò molti di soldi ma allo stesso tempo permise ai viaggiatori di risparmiare anni di fatiche e sofferenze sulle piste del West. Si pensi che in quel periodo da Genova a New York ci volevano 57 giorni di navigazione e altri 24 per raggiungere San Francisco; con soli 81 giorni si andava dall'Italia alla California.
Voglio raccontare qui di seguito la storia di mio nonno che emigrò negli Stati Uniti agli inizi del 1900. Più che di storia si tratta di vere e proprie disavventure che, per la maggior parte dei casi, si ripetono anche oggi nel nostro paese e nelle altre nazioni più industrializzate.Allora come adesso chi emigra, se è una persona onesta, è spinto da necessità economiche mentre a casa sua c'è miseria e fame. Spesso sono i parenti e gli amici partiti prima di lui a convincerlo ad andare, ma come fa se non ha un soldo? Allora come adesso, egli venderà quel poco che ha o si farà prestare del denaro da qualcuno, sperando poi di restituirlo. Emerge però subito il lato vergognoso della faccenda. Su questi disperati si avventano subito gli speculatori che, approfittando del loro stato d'indigenza ed ignoranza, li spingono ad indebitarsi per poter partire. Adesso come allora non viene detto che occorrono visti, permessi di soggiorno, che è difficile inserirsi e trovare un lavoro onesto, essi vengono dissanguati e mandati allo sbaraglio.
Senz'altro nel nostro paese ci sono tanti immigrati che si danno alla malavita ma molti altri sono persone oneste che troppo spesso vengono illuse e sfruttate.
Mio nonno emigrò la prima volta nel 1904 ed aveva 24 anni.A quei tempi in ogni comune esisteva un "mediatore" o "sensale" di una compagnia di navigazione e spesso era il titolare dell'osteria del paese, il posto più idoneo dove propagandare i facili guadagni in America. Mi immagino il locale gremito di contadini il giorno di festa, un loquace e smaliziato imbonitore offrire da bere a quei poveri analfabeti decantando le fortune e le ricchezze facilmente reperibili oltre Oceano e... prezzi stracciati per il viaggio.
Quando mio nonno e i suoi compagni decisero di partire non sapevano nemmeno se sarebbero andati nel Nord o nel Sud America o tanto meno dove fossero; gli fu detto che andavano in America e basta. Erano una decina, chi di Montessoro, chi di Piazzo e Casissa; un giorno di Aprile presero il treno e furono condotti a Le Havre, in Francia.Nell'Ottocento quasi tutti gli emigranti partivano da questo porto perché solo da lì esistevano linee dirette per New York e di conseguenza i prezzi erano più economici. Il viaggio con partenza da Genova era più lungo perchè si toccavano molti altri scali.
Il costo del passaggio era di circa 360 lire e a volte comprendeva anche un accompagnatore che attraverso la Svizzera li conduceva al porto francese.
La sera precedente la partenza la passarono all'osteria a bere e fare allegria, poi a notte inoltrata partirono con i loro miseri fagotti e raggiunsero Isola che ancora non faceva giorno.
Chissà quali pensieri passarono per la mente di mio nonno, quando dal treno vide le sue montagne per l'ultima volta...
All'imbarco sulla nave "La Touraine" gli emigranti erano divisi, uomini da una parte donne e bambini dall'altra, poi venivano sistemati in terza classe nei fondi della nave. Per tutta la traversata essi non potevano uscire ne salire sui ponti che erano riservati a passeggeri più abbienti. La prima traversata dell'Oceano per quei poveri montanari fu terribile; il mare in tempesta faceva scricchiolare il fasciame e si rischiò il naufragio, la gente vomitava e la puzza era insopportabile, molti furono presi dal panico e disperavano di arrivare a destinazione. La nave comunque riuscì ad attraccare a New York l'1 maggio 1904.
Una volta arrivati gli emigranti venivano condotti al Castle Garden; questa era la sede dell'ufficio immigrazione degli Stati Uniti, esso si trovava sulla punta di Manhattan, a Battery, successivamente, essendo ormai inadatta per poter ospitare i grandi flussi migratori l'ufficio venne spostato a Hellis Island, un isolotto nella baia di New York vicino alla statua della Libertà.Qui essi erano sottoposti a visita medica e controllo dei documenti; la visita era sommaria, si controllavano gli occhi, si verificava che si fosse sani di mente. Gli uomini oltre i 45 anni venivano respinti in quanto troppo vecchi e poco adatti come "forza lavoro"; si controllava anche che non si fosse anarchici, che si avesse un lavoro ed un recapito. Agli idonei veniva fatta una croce sulla schiena con il gesso. Quando venne il turno dei nostri montanari l'ufficiale addetto ai controlli chiese se avevano una richiesta di lavoro o qualche parente che li aspettasse, ma ignari di tutto ciò, venne detto loro che sarebbero stati rimpatriati con il primo vapore per l'Italia.Vi potete immaginare in quale stato d'animo si sentissero, dopo tanti sacrifici essi rischiavano di veder vanificate tutte le loro speranze. La giornata passò fra disperazione e pianti quando verso sera si presentò all'ufficio immigrazione un italo-americano il quale disse che avrebbe provveduto lui stesso a quei disperati. La malavita si era messa in moto, gli italiani che già vivevano a New York si erano organizzati nello sfruttare queste situazioni speculando sui nuovi arrivati. A questi disgraziati veniva offerto un tugurio ed un lavoro in cambio di una tangente o spesso erano inviati lontano, affittati ad altri malavitosi.L'individuo che salvò in nostri si fece consegnare una discreta somma, li portò alla stazione, infilò nella falda del cappello un biglietto ferroviario e li spedì in California.
Avrei voluto vedere le loro facce smarrite mentre passavano tra il traffico ed i grattacieli di New York, loro che forse non erano nemmeno mai stati a Genova.Il grande treno piano piano si mise in moto e cominciò ad ingoiare pianure e città. I nostri amici adesso erano un po' più sollevati ma nessuno li accompagnava, sapevano solo che sarebbero andati in California a raccogliere la frutta, all'arrivo qualcuno li avrebbe prelevati.
Il viaggio era lungo, da New York a San Francisco occorrevano otto giorni. Poveri montanari, non erano mai usciti dal loro paese ed adesso si trovavano ad attraversare le grandi pianure, le Montagne Rocciose, i Canyons.
Nessuno parlava inglese e forse pochi si esprimevano in italiano. Il treno sbuffando macinava chilometri e chilometri, ogni tanto passava nei corridoi un negro vestito di bianco (un cameriere o uno stewart) che diceva "breackfast, breackfast..." avvisando che si poteva scendere dal treno per poter fare colazione; datosi però che i nostri non capivano nulla non scendevano per il timore di rimanere a terra. La cosa andò avanti per alcuni giorni, fin quando, presi dai morsi della fame ad una stazione uno di loro scese per comprare un po' di pane ma, prima che questi si fosse fatto capire, il treno si rimise in marcia. Per fortuna il capotreno, allertato dalle urla, tirò una cordicella e fermò il treno per recuperare il malcapitato!
Dopo otto giorni giunsero a Sacramento, già qualcuno li aspettava e li condusse ad una grande fattoria dove insieme a centinaia di persone vennero mandati a raccogliere frutta e verdura. Tante ore di lavoro, pochi soldi e tanta fame. Una volta si rifiutarono di lavorare perché da giorni non gli veniva distribuito nemmeno un po' di pane.
In queste immense piantagioni vi erano persone provenienti da tutto il mondo; mio nonno raccontava che c'erano tantissimi cinesi e che quando parlavano sembravano tanti uccellini cinguettanti.
Quando nel 1906 il terremoto distrusse San Francisco egli si trovava alla periferia della città e con i compagni si rifugiò sulle montagne, dove trovarono lavoro come taglialegna. Dormivano in una tenda ma avevano paura degli indiani e ogni rumore li teneva svegli.
Mio nonno stette in California circa quattro anni, lavorò a Sacramento, Stockton, San Francisco, Reno Nevada ma di soldi ne fece ben pochi. Come spesso accade ad arricchirsi erano i più furbi ed i disonesti.
Tornato a casa nel 1908 nel 1909 prese moglie, nel 1910 nacque mio padre. Nel 1912 arrivò un secondo figlio; in quell' anno, non si sa per quale motivo ma probabilmente per la vita precaria che si conduceva sui nostri monti, lasciò mia nonna con i due figli piccolini e decise di ritentare la fortuna, ancora alla volta della California.
Con l'esperienza acquisita durante il primo viaggio trovò la vita un pochino più facile e con altri paesani lavorò a San Francisco con un'impresa per la raccolta dei rifiuti. Si deve sapere che già da quando nel 1906 il terremoto distrusse la città, molti liguri ebbero il permesso di raccogliere e riciclare il materiale di un certo valore, dopodichè, vedendo che nessuno raccoglieva la spazzatura alla porta delle case, lo fecero loro e con dei carri a cavallo la depositavano nelle fenditure provocate dal sisma. Questi uomini erano chiamati "scavengers", poi con gli anni ebbero l'esclusiva di questo lavoro e fondarono la "Pacific Scavengers Company".
Un divertente ma inquietante aneddoto viene raccontato dall'ex giudice federale John Molinari che dice: "Cinquant'anni fa mio padre Giovanni che nel 1906 era uno "scavenger", prese una mappa della città e indicando diversi punti mi disse di non comprare mai casa in detti luoghi. Subito non capii, ma quando nel 1989 un secondo terremoto colpì la città, le rovine più gravi avvennero proprio in quei punti dove loro avevano depositato i rifiuti".
Il lavoro era duro ma dopo qualche anno i frutti cominciarono a vedersi. Nel 1914 il nonno scrisse a casa chiedendo alla moglie di raggiungerlo; ma lei impaurita dal lungo viaggio da intraprendere con due bambini piccoli, rispose negativamente. Pur sapendo dell'imminente scoppio della guerra egli rientrò in Italia. Nel 1915 gli nacque un altro figlio e subito dopo venne spedito sul Carso; ritornerà nel 1918. Mia nonna rimase complessivamente sola con i figli per otto anni.
Ancora oggi nei nostri paesi vengono usate delle parole ormai corrotte che vennero introdotte dagli emigranti rientrati.
Per indicare un poco di buono si usa dire: "O l'è un trampa" (da tramp = vagabondo), oppure "O l'è un "sanebabicciu" (da "son of a bitch" = figlio di una cagna ).Poca per Poker. Trac per Truck. Cino per Cinese. Indio per Indiano. Rancio per Ranch.
Bibliografia
La fatica e la Merica - M. Porcella
Il mondo dei vinti - N. Revelli
"Sette" rivista de "La Repubblica" del 09.10.2003 - "Ieri noi oggi loro" - M. Moretti
Rivista "Qui Touring" luglio-agosto 2001
"Il Secolo XIX" del giorno 16.01.2002 - "Ma i liguri non partivano né poveri né disperati" - L. Compagnino
"Il Secolo XIX" del giorno 26.11.2002 - "Quando i poveri eravamo noi" - A. Gibelli
"Il Secolo XIX" del giorno 22.08.2001 - "Ramazza e cioccolato" - G. Mari
La Casana "Con i liguri in California" - Ida Figone Filippetti
Enciclopedia "Il Milione" - Nicaragua
Enciclopedia GE20
La via delle Americhe - Fondo Regionale C. Colombo - Centro Ligure di Storia sociale
Sito internet "The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation"
Le storie d'immigrati che giornalmente ci appaiono in televisione e sulla stampa mi riportano ai racconti di mio nonno che era nato al Piazzo (Isola del Cantone) nel 1880 ed emigrò in California agli inizi del 1900.In cento anni, dal 1876 al 1976 circa, emigrarono 27 milioni di italiani; i nostri avi sono stati costretti ad emigrare verso i paesi più ricchi poichè da noi si moriva letteralmente di fame. Nel 1903 l'età media in Italia era di 25 anni. Tra il 1891 e il 1900 su 759.000 morti, 333.000 avevano meno di 5 anni.
Laceri, sporchi e analfabeti, erano imbarcati nelle stive stracolme di altri disperati provenienti dalle nazioni povere dell'Europa: Turchia, Grecia, Polonia ecc. Spesso non sapevano nemmeno dove la nave li avrebbe portati. Sbarcavano in paesi dove la gente non li aspettava di certo a braccia aperte. La maggior parte finiva per vagabondare e si dava all'accattonaggio, altri finivano nella malavita organizzata; i più furbi vivevano di espedienti, i più onesti venivano sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli.
Inizierò riportando alcune notizie riguardanti quegli emigranti che una volta giunti negli Stati Uniti volevano raggiungere la mitica California.
Pensando a questo lungo viaggio la prima cosa che ci viene in mente è quella delle lunghe carovane di pionieri che si spingevano sui pericolosi sentieri del Far West. Ciò non è però del tutto vero perché questa consueta immagine c'è stata inculcata dai mitici film western che abbiamo visto al cinema. Forse non tutti sanno che dal 1850 tanti emigranti per poter raggiungere la costa del Pacifico non viaggiavano via terra ma via mare.
Nel 1848, quando in California fu scoperto l'oro e vi fu la famosa corsa verso l'Ovest, per attraversare gli Stati Uniti l'unica via era la "California Trail", una pista lunga 3000 chilometri, e per arrivare a destinazione, se si arrivava, occorrevano anni. Una seconda alternativa, che molti sfruttavano, era quella di andare via mare passando per il Capo Horn ed impiegando 160 giorni; successivamente con i più veloci "cutter" ci volevano 60 giorni. A quell'epoca non c'erano altre scelte anche perché la costruzione della prima ferrovia New York - San Francisco iniziò soltanto nel 1862 ed i lavori furono ultimati nel 1869.
Una geniale idea venne allora al finanziere ed armatore americano Cornelius Vanderbilt il quale pensò di allestire una linea di traghetti da New York al Nicaragua e San Francisco.Bisogna sapere che in questo Stato del Centro America esiste un sistema naturale di vie navigabili che permette di passare dall'Oceano Atlantico al Pacifico senza la costruzione di canali artificiali; in questo modo i velieri di Vanderbilt partendo da New York attraversavano il Golfo del Messico e toccando la costa del Nicaragua a San Juan del Norte, risalivano il Rio San Juan che è navigabile e raggiungevano il Lago Nicaragua. Sulla costa occidentale di questo grande lago gli emigranti venivano fatti sbarcare e con vari mezzi attraversavano i 20 chilometri di giungla che separavano il lago dal porto di San Juan del Sur sul Pacifico. Da qui venivano imbarcati su un altro battello che li trasportava a San Francisco in California. Sembra addirittura che Mr. Vanderbilt, con l'appoggio degli Stati Uniti coltivasse un progetto per costruire nel tratto di terraferma un canale navigabile ma nel 1850 in base al trattato Clayton-Bulswer, l'Inghilterra non concesse l' esecuzione di tali lavori, un vero peccato se si pensa che il Canale di Panama venne aperto soltanto nel 1917.
In quegli anni il viaggio New York/San Juan del Norte durava 7 giorni mentre da San Juan del Sur a San Francisco ne occorrevano 17: in totale erano 24 giorni.
In quel periodo, comunque, oltre alla via del Nicaragua gli emigranti potevano raggiungere il Pacifico anche attraverso Panama (porto di Aspinwall), che come abbiamo visto non aveva ancora il canale, ma una ferrovia ultimata nel 1855, collegava le sponde dei due oceani. In questo caso però occorrevano 35 giorni.
L'armatore americano ebbe senz'altro una grande idea che gli fruttò molti di soldi ma allo stesso tempo permise ai viaggiatori di risparmiare anni di fatiche e sofferenze sulle piste del West. Si pensi che in quel periodo da Genova a New York ci volevano 57 giorni di navigazione e altri 24 per raggiungere San Francisco; con soli 81 giorni si andava dall'Italia alla California.
Voglio raccontare qui di seguito la storia di mio nonno che emigrò negli Stati Uniti agli inizi del 1900. Più che di storia si tratta di vere e proprie disavventure che, per la maggior parte dei casi, si ripetono anche oggi nel nostro paese e nelle altre nazioni più industrializzate.Allora come adesso chi emigra, se è una persona onesta, è spinto da necessità economiche mentre a casa sua c'è miseria e fame. Spesso sono i parenti e gli amici partiti prima di lui a convincerlo ad andare, ma come fa se non ha un soldo? Allora come adesso, egli venderà quel poco che ha o si farà prestare del denaro da qualcuno, sperando poi di restituirlo. Emerge però subito il lato vergognoso della faccenda. Su questi disperati si avventano subito gli speculatori che, approfittando del loro stato d'indigenza ed ignoranza, li spingono ad indebitarsi per poter partire. Adesso come allora non viene detto che occorrono visti, permessi di soggiorno, che è difficile inserirsi e trovare un lavoro onesto, essi vengono dissanguati e mandati allo sbaraglio.
Senz'altro nel nostro paese ci sono tanti immigrati che si danno alla malavita ma molti altri sono persone oneste che troppo spesso vengono illuse e sfruttate.
Mio nonno emigrò la prima volta nel 1904 ed aveva 24 anni.A quei tempi in ogni comune esisteva un "mediatore" o "sensale" di una compagnia di navigazione e spesso era il titolare dell'osteria del paese, il posto più idoneo dove propagandare i facili guadagni in America. Mi immagino il locale gremito di contadini il giorno di festa, un loquace e smaliziato imbonitore offrire da bere a quei poveri analfabeti decantando le fortune e le ricchezze facilmente reperibili oltre Oceano e... prezzi stracciati per il viaggio.
Quando mio nonno e i suoi compagni decisero di partire non sapevano nemmeno se sarebbero andati nel Nord o nel Sud America o tanto meno dove fossero; gli fu detto che andavano in America e basta. Erano una decina, chi di Montessoro, chi di Piazzo e Casissa; un giorno di Aprile presero il treno e furono condotti a Le Havre, in Francia.Nell'Ottocento quasi tutti gli emigranti partivano da questo porto perché solo da lì esistevano linee dirette per New York e di conseguenza i prezzi erano più economici. Il viaggio con partenza da Genova era più lungo perchè si toccavano molti altri scali.
Il costo del passaggio era di circa 360 lire e a volte comprendeva anche un accompagnatore che attraverso la Svizzera li conduceva al porto francese.
La sera precedente la partenza la passarono all'osteria a bere e fare allegria, poi a notte inoltrata partirono con i loro miseri fagotti e raggiunsero Isola che ancora non faceva giorno.
Chissà quali pensieri passarono per la mente di mio nonno, quando dal treno vide le sue montagne per l'ultima volta...
All'imbarco sulla nave "La Touraine" gli emigranti erano divisi, uomini da una parte donne e bambini dall'altra, poi venivano sistemati in terza classe nei fondi della nave. Per tutta la traversata essi non potevano uscire ne salire sui ponti che erano riservati a passeggeri più abbienti. La prima traversata dell'Oceano per quei poveri montanari fu terribile; il mare in tempesta faceva scricchiolare il fasciame e si rischiò il naufragio, la gente vomitava e la puzza era insopportabile, molti furono presi dal panico e disperavano di arrivare a destinazione. La nave comunque riuscì ad attraccare a New York l'1 maggio 1904.
Una volta arrivati gli emigranti venivano condotti al Castle Garden; questa era la sede dell'ufficio immigrazione degli Stati Uniti, esso si trovava sulla punta di Manhattan, a Battery, successivamente, essendo ormai inadatta per poter ospitare i grandi flussi migratori l'ufficio venne spostato a Hellis Island, un isolotto nella baia di New York vicino alla statua della Libertà.Qui essi erano sottoposti a visita medica e controllo dei documenti; la visita era sommaria, si controllavano gli occhi, si verificava che si fosse sani di mente. Gli uomini oltre i 45 anni venivano respinti in quanto troppo vecchi e poco adatti come "forza lavoro"; si controllava anche che non si fosse anarchici, che si avesse un lavoro ed un recapito. Agli idonei veniva fatta una croce sulla schiena con il gesso. Quando venne il turno dei nostri montanari l'ufficiale addetto ai controlli chiese se avevano una richiesta di lavoro o qualche parente che li aspettasse, ma ignari di tutto ciò, venne detto loro che sarebbero stati rimpatriati con il primo vapore per l'Italia.Vi potete immaginare in quale stato d'animo si sentissero, dopo tanti sacrifici essi rischiavano di veder vanificate tutte le loro speranze. La giornata passò fra disperazione e pianti quando verso sera si presentò all'ufficio immigrazione un italo-americano il quale disse che avrebbe provveduto lui stesso a quei disperati. La malavita si era messa in moto, gli italiani che già vivevano a New York si erano organizzati nello sfruttare queste situazioni speculando sui nuovi arrivati. A questi disgraziati veniva offerto un tugurio ed un lavoro in cambio di una tangente o spesso erano inviati lontano, affittati ad altri malavitosi.L'individuo che salvò in nostri si fece consegnare una discreta somma, li portò alla stazione, infilò nella falda del cappello un biglietto ferroviario e li spedì in California.
Avrei voluto vedere le loro facce smarrite mentre passavano tra il traffico ed i grattacieli di New York, loro che forse non erano nemmeno mai stati a Genova.Il grande treno piano piano si mise in moto e cominciò ad ingoiare pianure e città. I nostri amici adesso erano un po' più sollevati ma nessuno li accompagnava, sapevano solo che sarebbero andati in California a raccogliere la frutta, all'arrivo qualcuno li avrebbe prelevati.
Il viaggio era lungo, da New York a San Francisco occorrevano otto giorni. Poveri montanari, non erano mai usciti dal loro paese ed adesso si trovavano ad attraversare le grandi pianure, le Montagne Rocciose, i Canyons.
Nessuno parlava inglese e forse pochi si esprimevano in italiano. Il treno sbuffando macinava chilometri e chilometri, ogni tanto passava nei corridoi un negro vestito di bianco (un cameriere o uno stewart) che diceva "breackfast, breackfast..." avvisando che si poteva scendere dal treno per poter fare colazione; datosi però che i nostri non capivano nulla non scendevano per il timore di rimanere a terra. La cosa andò avanti per alcuni giorni, fin quando, presi dai morsi della fame ad una stazione uno di loro scese per comprare un po' di pane ma, prima che questi si fosse fatto capire, il treno si rimise in marcia. Per fortuna il capotreno, allertato dalle urla, tirò una cordicella e fermò il treno per recuperare il malcapitato!
Dopo otto giorni giunsero a Sacramento, già qualcuno li aspettava e li condusse ad una grande fattoria dove insieme a centinaia di persone vennero mandati a raccogliere frutta e verdura. Tante ore di lavoro, pochi soldi e tanta fame. Una volta si rifiutarono di lavorare perché da giorni non gli veniva distribuito nemmeno un po' di pane.
In queste immense piantagioni vi erano persone provenienti da tutto il mondo; mio nonno raccontava che c'erano tantissimi cinesi e che quando parlavano sembravano tanti uccellini cinguettanti.
Quando nel 1906 il terremoto distrusse San Francisco egli si trovava alla periferia della città e con i compagni si rifugiò sulle montagne, dove trovarono lavoro come taglialegna. Dormivano in una tenda ma avevano paura degli indiani e ogni rumore li teneva svegli.
Mio nonno stette in California circa quattro anni, lavorò a Sacramento, Stockton, San Francisco, Reno Nevada ma di soldi ne fece ben pochi. Come spesso accade ad arricchirsi erano i più furbi ed i disonesti.
Tornato a casa nel 1908 nel 1909 prese moglie, nel 1910 nacque mio padre. Nel 1912 arrivò un secondo figlio; in quell' anno, non si sa per quale motivo ma probabilmente per la vita precaria che si conduceva sui nostri monti, lasciò mia nonna con i due figli piccolini e decise di ritentare la fortuna, ancora alla volta della California.
Con l'esperienza acquisita durante il primo viaggio trovò la vita un pochino più facile e con altri paesani lavorò a San Francisco con un'impresa per la raccolta dei rifiuti. Si deve sapere che già da quando nel 1906 il terremoto distrusse la città, molti liguri ebbero il permesso di raccogliere e riciclare il materiale di un certo valore, dopodichè, vedendo che nessuno raccoglieva la spazzatura alla porta delle case, lo fecero loro e con dei carri a cavallo la depositavano nelle fenditure provocate dal sisma. Questi uomini erano chiamati "scavengers", poi con gli anni ebbero l'esclusiva di questo lavoro e fondarono la "Pacific Scavengers Company".
Un divertente ma inquietante aneddoto viene raccontato dall'ex giudice federale John Molinari che dice: "Cinquant'anni fa mio padre Giovanni che nel 1906 era uno "scavenger", prese una mappa della città e indicando diversi punti mi disse di non comprare mai casa in detti luoghi. Subito non capii, ma quando nel 1989 un secondo terremoto colpì la città, le rovine più gravi avvennero proprio in quei punti dove loro avevano depositato i rifiuti".
Il lavoro era duro ma dopo qualche anno i frutti cominciarono a vedersi. Nel 1914 il nonno scrisse a casa chiedendo alla moglie di raggiungerlo; ma lei impaurita dal lungo viaggio da intraprendere con due bambini piccoli, rispose negativamente. Pur sapendo dell'imminente scoppio della guerra egli rientrò in Italia. Nel 1915 gli nacque un altro figlio e subito dopo venne spedito sul Carso; ritornerà nel 1918. Mia nonna rimase complessivamente sola con i figli per otto anni.
Ancora oggi nei nostri paesi vengono usate delle parole ormai corrotte che vennero introdotte dagli emigranti rientrati.
Per indicare un poco di buono si usa dire: "O l'è un trampa" (da tramp = vagabondo), oppure "O l'è un "sanebabicciu" (da "son of a bitch" = figlio di una cagna ).Poca per Poker. Trac per Truck. Cino per Cinese. Indio per Indiano. Rancio per Ranch.
Bibliografia
La fatica e la Merica - M. Porcella
Il mondo dei vinti - N. Revelli
"Sette" rivista de "La Repubblica" del 09.10.2003 - "Ieri noi oggi loro" - M. Moretti
Rivista "Qui Touring" luglio-agosto 2001
"Il Secolo XIX" del giorno 16.01.2002 - "Ma i liguri non partivano né poveri né disperati" - L. Compagnino
"Il Secolo XIX" del giorno 26.11.2002 - "Quando i poveri eravamo noi" - A. Gibelli
"Il Secolo XIX" del giorno 22.08.2001 - "Ramazza e cioccolato" - G. Mari
La Casana "Con i liguri in California" - Ida Figone Filippetti
Enciclopedia "Il Milione" - Nicaragua
Enciclopedia GE20
La via delle Americhe - Fondo Regionale C. Colombo - Centro Ligure di Storia sociale
Sito internet "The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation"






























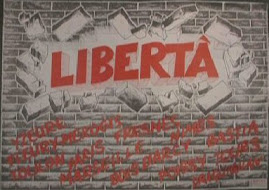









pettoleg.jpg)



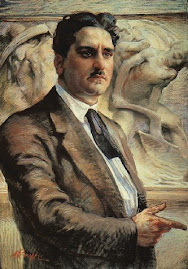























.jpg)


















.jpg)


































































































.jpg)

















































.jpg)